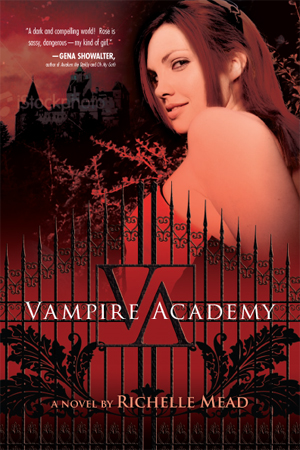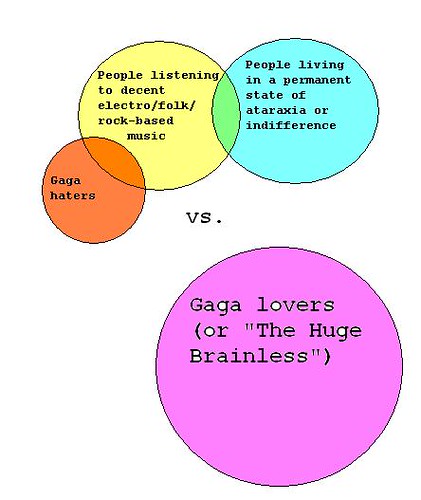Conclusa la
chiacchierata ho subito realizzato quale sarebbe stata la maggiore difficoltà da affrontare, ragione per la quale,
intervistare sarà per me attività
centellinata e di parco dosaggio.
INGABBIARE PENSIERI. Ingabbiare pensieri personali è già di per sé percorso tortuoso. Quando si tratta poi di cercare di catturare e riprodurre quelli degli altri, beh, diventa persino ansiogeno.
Concordate le premesse, mi dispongo a darvi qualche informazione sull'intervistata.
Sto per avere una fertile
conversazione con
Elisabetta Benfatto, giovane e
talentuosa fumettista veneta (si occupa anche di attività nel campo grafico e
illustrativo) che, per fare qualche nome fra i tanti, pubblica e ha pubblicato su
ANIMAls,
Hamelin, Linea grafica,
Fabrica Files (..) Ah. Se non bastasse è anche docente presso la sede padovana dell'
Internazionale Comics.
Ad ogni modo tutte le
informazioni a riguardo le trovate su
http://www.elisabettabenfatto.blogspot.com/ e potrete ben notare da soli che le citazioni fatte sono
percentualmente infinitesimali nel suo curriculum.
La
chiacchierata inizia in modo casuale, all'aria aperta, mentre ci dirigiamo affamate verso il più vicino bar.
E.B."(..)Io sono piuttosto
anti tecnologica, preferisco presenziare il p
iù possibile fisicamente quando vengono presentati i miei lavori o comunque le opere alle quali ho collaborato e farmi conoscere così. Anche se devo dire che il computer è
assolutamente necessario e, di necessità virtù, ho dovuto imparare ad usarlo perlomeno
discretamente bene."
ES." Sì è vero. E' necessario. Anche se sull'uso del computer nel campo dell'
illustrazione io ho una posizione piuttosto hard core. Mi spiego. Tutte queste nuove
illustrazioni, animazioni fatte a tavoletta grafica,
photoshop e chi più ne ha più ne metta..non mi piacciono.
Personalmente trovo che non sia
illustrazione VERA. E' asettica, impersonale. E volendo passare dal punto di vista del fruitore a quello dell'
illustratore.. Beh. forse è anche peggio. Il disegno non ti porta più. Fai un errore mentre lo esegui e ..
bon. Freccetta indietro e dell'errore non v'è più traccia. Non c'è più la necessità di un'idea in aggiunta alla prima per cercare di camuffare l'errore e renderlo parte dell'opera. Diventa statico. Non sei più condotto da nessuna parte."
E.B." Mi trovi
assolutamente d'accordo. Penso che, soprattutto in fase di formazione dell'artista, sia pericoloso essere supportati dal computer. La mano è uno strumento di conoscenza e va allenata con primaria urgenza. Pensa solo che una volta anche che ne so, gli archeologi, gli esploratori gli scienziati.. non potevano fotografare, scannerizzare o vattelapesca. Lo studio e la diffusione della conoscenza avvenivano in larga porzione tramite appunti disegnati. Non vi era altro strumento. Il computer è utilissimo come mezzo, ma deve essere di supporto, quando si è già formati e consapevoli dell'uso che se ne fa. Il disegno a mano ha spesso un altro sapore, più grezzo, più vicino a noi. E come diceva Mozart "la bellezza sta nell'imperfezione".
ES." e io che pensavo fosse farina del mio sacco."
..Piccoli eghi smisurati crescono.
Siamo arrivate al bar, abbiamo ordinato e preso posto al tavolino. Tesa e con le mani sudaticce, ho tirato fuori la cartellina degli appunti per fare le domande e nascondermi dietro un'aria para professionale.
ES. " Beh, inizierei con una domanda banale che poi cosi' banale forse non è. In cosa cosiste il Suo lavoro?"
E.B " Altro che banale. Questa è una domanda complessa. Ah, e dammi del tu! Vediamo.. Sì. Ti rispondo così. Il mio lavoro consiste nell'essere un essere umano. Nel seguire una vocazione e un bisogno primario di comunciarsi e comunicare col proprio strumento. Non saprei dirlo in un altro modo. Per scelta credo sia giusto non razionalizzare questi discorsi e comunicarli come si sentono. E anche se può suonare da artistoide o comunque strano io lo vivo così. Tu dai agli altri il tuo sguardo sul mondo.
ES. " ..e qui capisco la sua citazione-manifesto di Picasso presente nel Suo, orco, TUO blog.
(Riporto. : " ..
spesso lo "stile" è qualcosa che vincola l'artista a uno stesso modo di vedere, alla stessa tecnica, le stesse formule anno dopo anno, qualche volta anche per tutta la vita. Lo si riconosce subito ma è sempre lo stesso vestito, è lo stesso taglio di abito. Tuttavia ci sono grandi pittori che hanno stile. Io invece mi agito troppo, vagabondo troppo. Tu mi vedi qua, e io sono già cambiato, sono da un'altra parte. Io non sono mai vincolato e per questo non ho uno stile.")
E.B. " Esattamente. Ovvviamente, ribadisco, tutto quello che ti dico è da riferirsi unicamente al mio percorso e al mio modo di percepire le cose. Spesso, a mio avviso avere uno stile di tratto, di disegno, di tecnica può diventare una gabbia per l'artista. Sì, sei riconoscibile, ma rischi di ripeterti e fermare un percorso personale che puo' essere molto più ampio. Il vero stile, lo stile in senso puro, è il tuo modo di vedere e vivere le cose che è unico: già da solo cifra distintiva artistica. Ed ecco come il mio lavoro è di diversi generi e formati."
(Nel mentre mi rendo conto che posso anche mettere via la penna con la quale volevo ingenuamente prendere appunti e decido di rischiare di far affidamento sulla memoria. Quindi la metto via e cerco di aprire ancora meglio orecchie e cervello.)
ES. "..lavoro. Ma è effettivamente qualcosa che ha una durata lavorativa nell'arco della giornata? otto ore pausa pranzo e tutti a casa a mangiare la pizza?"
E.B " Assolutamente no. Anzi, ti direi che è un processo senza margini,
fastidiosamente continuo. Questo mestiere ha alla base la curiosità, l'osservare al posto del vedere, l'osservare anche ad occhi chiusi. Non c'è mai tregua, ogni cosa, anche la più piccina è spunto per qualcos'altro. Io per staccare uso lo sport, che è l'unica cosa che mi permette di NON pensare. Cammino, cammino tanto. Ma quello che più di tutto mi permette di staccare la spina è una bella nuotata."
ES. " Altrimenti si soffoca. In che rapporto è con la Sua creatività?"
E.B. " Ma dammi pure del tu che mi fa strano sennò!"
ES. "Porca vacca, mi scusi, orco, scusa, è più forte di me. In che rapporto sei con la tua creatività?" (e intanto canticchio fra me e me
I'm a loser dei Beatles)
E.B. "Anche questa, domanda non facile. Per me disegnare, come raccontare, è una forma interrogativa continua. Non vi è distinzione fra bozzetto ed esecutivo, come non vi è distinzione di passato e presente fra i segni. Tutto converge in un unico punto di indagine che è senza tempo, oppure, se bisogna darne uno, presente. Anche se il tempo fisico nello sviluppo delle opere scorre, il tempo artistico di un opera è unico."
ES. "E qual'è il Suo rapporto con le opere invece?" (Cazzo.
I'm a looooooser)
EB. "Io mi sento loro figlia. Non sono fautrice di quello che poi, nel pratico
eseguo. Sono figlia della loro esperienza. Devo viverle. E' fondamentale però che ci sia una sorta di distacco fra me e loro. Se faccio qualcosa e ne sono troppo coinvolta, so che quello che produrrò non sarà efficace. Il mio sentire deve essere elemento componente, ma non unico. E forse a "prodotto" finito, non riconoscibile perchè mescolato con il resto."
ES."Si può vivere solo di illustrazione?"
EB. " Sì, ci si puo' vivere, ma a lungo termine. Non è materiale di sostentamento immediato. All' inizio le contingenze ti portano a fare un po' di tutto. Anche consegnare pizze. Se sei fortunato trovi qualcosa che non è il tuo vero lavoro ma ci si puo' avvicinare. Io per esempio ho lavorato tre anni e mezzo in uno studio di grafica, alla fine pero' non avevo quasi più tempo per disegnare e iniziavo a stare male, perchè mi mancava. Ho imparato molto, ma poi sono stata naturalmente ricondotta alle mie origini."
ES. "Volenti o nolenti, il mondo della creatività è ancora luogo dove l'uomo la fa da padrone. Ha mai sentito condizionamenti o vincoli per questa ragione?"
EB. " Nonostante ci siano diverse figure femminili che si stanno facendo largo, è innegabile dire che, sì, gli uomini sono ancora dominanti in questo settore. Ho lavorato spesso in team interamente (a mia esclusione) maschili e devo dire che non ho sentito particolari pressioni. Anche se una cosa va detta. Questa parità nel lavorare assieme l'ho vissuta soprattutto con artisti stranieri. Nessuno spagnolo, inglese o tedesco mentre si lavora si sognerebbe mai di fare battutine sulla tua sessualità, ma perchè proprio non viene loro spontaneo farle. L'italiano invece qui si riconosce, e qualche battuta, la fa."
Come aspettarsi qualcosa di diverso da un popolo che a capo ha un politico che nelle foto di gruppo si sollazza facendo le corna?Ma questa è un'altra storia.
ES."Cosa Le piacerebbe fare in futuro?" (
e dajela)
E.B." Come ti ho già detto alla base di questo lavoro c'è la curiosità. Di conseguenza mi piacerebbe provare a farlo anche all'estero. Sicuramente un passaggio per la Francia
(n.d.r. paese dove la cultura dei comics e dell'illustrazione è affermata e decisamente meglio retribuita che in Italia) lo farò"
ES. "Il mio sogno è andare in Canada"
EB. "Bingo. Anche a me quando espatrierò, piacerebbe andare soprattutto fuori dall'Europa. Qui, bene o male ,abbiamo un pensiero vecchio, già formato. Mi piace l'idea di poter conoscere qualcosa di nuovo e di diverso."
ES." Cambierebbe qualcosa della Sua formazione artistica?
(tutto sto Lei. Non mi facevo così educata)
EB." Assolutamente sì. Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Venezia e ho trovato tremendo (ovviamente con i dovuti distunguo ad personam al suo interno) il fatto che a diciotto anni invece di sfruttare l'occasione d'imparare da un maestro, si dovesse andare a dimostrare di essere artisti. Non sei un'artista a diciotto anni. O meglio lo sei in potenza, ma hai bisogno di qualcuno che ti mostri le strade e ti disciplini. Il tempo per imparare con efficacia viene una sola volta nella vita. A trent'anni, anche se è triste dirlo, non sei più ricettivo come a venti. Sei già consolidato come persona quindi, anche giustamente, più impermeabile agli insegnamenti. C'è anche da dire che proprio da un professore universitario (quello di fotografia), a diciotto anni ho avuto la mia prima commissione di lavoro."
ES." Non tutto il male vien per nuocere. Quali sono stati per Lei i disegni di riferimento nella crescita?"
E.B"
(ride) Beh, da quando avevo circa tre anni disegno. Quindi Heidi, Jeeg Robot e l'Uomo Ragno. Pensa te che recentemente ho trovato in uno scatolone dei fumetti che facevo da piccola. Ma non ci sono i balloons con le parole. Facevo io le voci dopo aver disegnato.
(ride di nuovo, ridiamo anzi) Dopo averli ritrovati, sfogliandoli mi sono resa conto che mi stavo ripetendo ancora pezzi di dialoghi a memoria"
ES."Disegnatrice e doppiatrice. Questo lavoro l'ha mai portata ad aver rimpianti?"
EB." No, direi di no. E' un lavoro che bisogna, soprattutto voi (alunni) che state ancora imparando,vivere e farlo senza ansie. Anche perchè non è solo la bravura che conta, o meglio. Conta quanto il caso, l'essere nel posto giusto al momento giusto e via dicendo. Mai pensare troppo in là, ma pensare a quello che si sta facendo."
L'intervista si conclude più o meno qui. Ci lasciamo (non mi permette di pagare) soddisfatte e forse anche un po' stordite dell'entità dei discorsi.
Credo che la cosa principale che mi è rimasta dentro una volta decantati i discorsi, sia che bisogna imparare ad imparare e a disporsi alle cose nel modo più naturale possibile.
Sicuro è che non ho imparato a darLe del tu.
 Ora, non so se vi sia sfuggito un insignificante dettaglio: siamo in guerra con la Libia. Okay, forse dire “siamo” non è la parola giusta, visto che noi non sganciamo bombe, non spariamo, non attacchiamo soldati, mercenari, eccetera eccetera (insomma, siamo lì per fare una passeggiatina in Libia a quanto pare! Un po’ di sano turismo internazionale!) ma comunque al momento lì è in corso una guerra. Che sia guerra umanitaria, non umanitaria, per il petrolio, lampo, lunga, tattica, di sfiancamento non me ne frega niente: stiamo (stanno) bombardando qualcosa? Muore della gente? Bene, quella è guerra. Il resto sono parole al vento.
Ora, non so se vi sia sfuggito un insignificante dettaglio: siamo in guerra con la Libia. Okay, forse dire “siamo” non è la parola giusta, visto che noi non sganciamo bombe, non spariamo, non attacchiamo soldati, mercenari, eccetera eccetera (insomma, siamo lì per fare una passeggiatina in Libia a quanto pare! Un po’ di sano turismo internazionale!) ma comunque al momento lì è in corso una guerra. Che sia guerra umanitaria, non umanitaria, per il petrolio, lampo, lunga, tattica, di sfiancamento non me ne frega niente: stiamo (stanno) bombardando qualcosa? Muore della gente? Bene, quella è guerra. Il resto sono parole al vento.