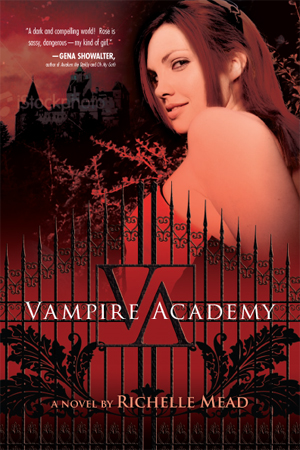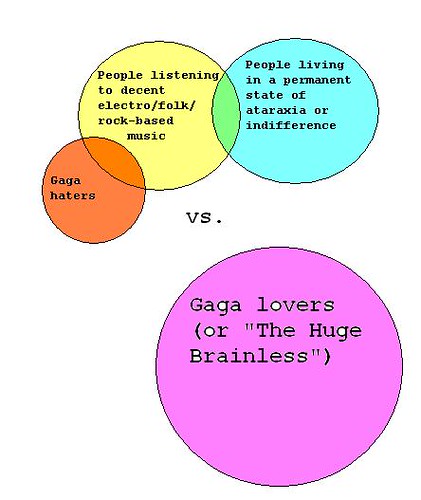I pavimenti della mia casa, così come li avevo vissuti per più di vent'anni, stavano per sparire ed essere sostituiti. Non c'erano sedie, poltrone, divani, bancali o altri oggetti che fungessero da spazio per la lettura.
Ricordo che un pomeriggio fui colta dalla rabbia; non trovavo più un libro che mi serviva e dolevo al pensiero di dover trascorrere gli ultimi giorni a casa, prima del mio trasferimento a Trento, in un paio di stanze dai pavimenti sfasciati, senza internet, senza corrente elettrica.
Tra martelli pneumatici, zanzare e operai molesti non potei far altro che sedermi in cima ad una scala e leggere l'ultimo numero de La Lotta Armata al Bar, che qualche ora prima mi era stato consegnato da Gabriele, uno dei fondatori della fanzine in questione.
Allo sguardo superficiale La Lotta Armata al Bar potrebbe sembrare un ridicolo tentativo di riproporre un'estetica e un medium che i nostri zii avevano dichiarato morto quando noi eravamo alle elementari. Forse anche prima.
Altre voci (per lo più di amici di amici di conoscenti vari) suggerirebbero invece l'interpretazione della Talpa Saputella, che parafrasata sarebbe questa:
“Questi tizi della Lotta Armata al Bar sono dei fattoni comunisti che parlano solo di sfasciarsi davanti al Cancelletto”.
Poco importa che lo sfasciarsi davanti al Cancelletto sia parte fondamentale della formazione di ogni giovane berico e che l'attività in questione non sia mai stata decantata – se la memoria non m'inganna - sulle pagine della fanzine di cui stiamo parlando.
Ma le Talpe Saputelle sono così. C'è poco da fare.
Abitano sotto terra e fruiscono servizi concepiti e messi in atto da Altri Generalizzati.
Io – la megalomane ed egocentrica Io – frequento invece il versante dei Pro Lotta Armata al Bar, per motivi socioculturali che includono un'adolescenza moderatamente merdosa, l'aver toccato con mano le perversioni delle istituzioni cattoliche beriche e la desolante assenza di cose-da-fare che mi portò ad essere l'unica deprecata ascoltatrice degli Smiths in una compagnia di metallari che mediamente avevano sedici mesi meno di me.
Di fronte a questioni simboliche che si fanno reali come muri di granito, come ad esempio il crepaccio che si apre tra scuole superiori e università (o chi per essa), dal mio punto di vista La Lotta Armata al Bar è quanto di più simile ad un prodotto culturale Degno (e dico Degno richiamando concetti alti e del tutto remoti rispetto alla nostra quotidiana esperienza) uno studente delle superiori possa reperire a Vicenza. Sì, poi in realtà ipotizzo che i lettori della fanza siano vari e che quindi non si concentrino solo nelle scuole. Ma il punto è che l'apparente rinascita culturale che si sta consumando sui tetti, nelle aiuole e nelle cantine della nostra terra ha investito solo in parte la popolazione minorenne berica, per motivi che varrà la pena di affrontare in separata sede.
Come si diceva sopra, La Lotta Armata al Bar parla la lingua che meglio si concilia con gli angoli dei corridoi nei quali eravamo soliti rifugiarci a ricreazione, pur introducendo temi e dibattiti che esulano dal più banale archetipo del Giornalino Scolastico Libertario o dalla Fanzine Politicizzata Tout-Court.
I contenuti sono assai vari e compositi, sempre in bilico tra il resoconto accurato di fatti d'attualità, l'autobiografismo e la narrazione pura.
Infine, vorrei dedicare questa riga alla celebrazione dei bei fumetti che accompagnano ogni numero e che in parte trovate anche sul sito della fanza.
Quella che segue è un'intervista ai tre fondatori de La Lotta Armata al Bar: Alessio, Bruno e Gabriele. Sempre siano lodati.
- Innanzitutto, chi si nasconde dietro al nome La lotta armata al bar?
Gabriele: Avrei bisogno di capire l’intenzione che sta dietro a questo “chi”. Se si intenda cioè chi nel senso degli autori, oppure un chi che voglia esplorare quello spettro nascosto tra le curve del nome “la lotta armata al bar”. Nel primo caso si tratta semplicemente di tre tizi stufi di lamentarsi per la mancanza di spazio di espressione che hanno provato a realizzare qualcosa, anche solo per vedere finalmente almeno un progetto andare in porto. Rispondendo a questa domanda mi rendo conto che anche la seconda domanda ha già trovato una parziale risposta: lo “spettro” altro non è che quello dell’apatia, si aggira inquieto per le pagine in bianco e nero ricordandoci continuamente che un modo di far qualcosa di bello c’è, e che siamo in grado di non soccombergli.
Bruno: siamo uno due tre molti individui, direi di giovine età, che hanno in comune poco, ma molta voglia di alzare il culone dal divano, spegnere la tv, e sognare come tutti dovrebbero.
- Qual è stata la genesi del vostro progetto?
Alessio: Un sabato sera Gabriele e un suo amico mi davano un passaggio e Gabriele per l'occasione mi mostrò delle fanzine che aveva appena comprato all'ex deposito95. Beh, le ho viste e subito mi son detto: devo farla anch'io.
Nel progetto ho da subito coinvolto Gabriele, che forse era ancora più lanciato di me, e Bruno che era il mio co-blogger, nonché, grandissimo amico ovviamente.
Gabriele: Una fortunata serie di coincidenze che ha fatto si che venissi in possesso di qualche copia di P.L.A.F. zine, mostrata poi ad Alessio. C’era già un buon terreno preparato chissà da quanto tempo in tutti noi, è bastato buttarci sopra qualche seme per far nascere questo piccolo progetto.
Bruno: un giorno alessio viene e mi chiede se butto giù qualche idea/qualunque cosa per fare una fanza, con lui e gabriele, di cui conoscevo solo i tratti somatici. ho risposto subito, forse, si, niente di mai provato perdiana!!
Gabriele: Una fortunata serie di coincidenze che ha fatto si che venissi in possesso di qualche copia di P.L.A.F. zine, mostrata poi ad Alessio. C’era già un buon terreno preparato chissà da quanto tempo in tutti noi, è bastato buttarci sopra qualche seme per far nascere questo piccolo progetto.
Bruno: un giorno alessio viene e mi chiede se butto giù qualche idea/qualunque cosa per fare una fanza, con lui e gabriele, di cui conoscevo solo i tratti somatici. ho risposto subito, forse, si, niente di mai provato perdiana!!
- Come mai avete deciso di investire Vicenza con un mezzo old-school come la cara vecchia fanza cartacea?
Alessio: più che investire su Vicenza, inizialmente abbiamo investito su di noi. La fanza cartacea è per l'appunto qualcosa di tattile oltre che visuale, la devi fare con le mani: forbici, colla e via. Può sembrare solo una sfumatura rispetto ad una webzine, ma in realtà, per me, rappresenta una caratteristica fondamentale: il blog che avevamo io e bruno non se lo cagava nessuno, con la fanza, nella quale ne abbiam messe di cose del vecchio blog, invece abbiam raggiunto un "pubblico" più vasto, ma soprattutto l'abbiamo raggiunto meglio perché si percepisce la differenza fra i due anche se gli scritti sono gli stessi: in una fanza il lettore vede un maggior coraggio, un maggiore sforzo lavorativo e dunque una maggior forza di volontà finendo per apportare una maggiore forza espressiva.
Gabriele: Non so se “investire” sia la parola giusta. Mi sembra un po’ troppo imponente e grandiosa. Direi che ci siamo infilati di sbiego un po’ alla volta nella quotidianità dei nostri conoscenti, cercando di coinvolgere il più possibile e di suscitare qualche tipo di reazione. Tenere in mano un libro o un giornale è ben diverso dal leggere su uno schermo, coinvolge il tatto, può coinvolgere l’olfatto. Inoltre una pagina richiede tempo per essere preparata e si fa un bel lavoro di forbici e colla che è bello recuperare dalle elementari!
Poi la grafica old-school ci piace dai, vuoi mettere il romanticismo di un collage fatto a mano? (si intenda il tutto con la dovuta ironia).
Bruno: innanzi tutto perchè siamo gente pratica, in secondo luogo come ho detto sopra, era una cosa nuova e mai vista, almeno da me, in ultima, se ti lanci su internet ti si filano tutti e nessuno, leggono e poi si dimenticano, perdono.. trovarsi carta stampata di fronte, da poter prendere con mano quando se ne ha necessità, è qualcosa di unico.. diciamo no all'immediatezza per piacere!
- Leggendo i primi cinque numeri de La lotta armata al bar e seguendo le vostre attività emerge chiaramente il vostro intento di dare spazio e voce alle band vicentine e italiane della scena-non scena indipendente. Da cosa nasce questa spinta verso le cantine e i garage?
Alessio: mi piace molto la musica e mi viene naturale parlarne nella nostra zine. La cantina e il garage sono per chi fa musica quello che la copisteria meno cara rappresenta per noi, dunque la ricerca di una modalità più spontanea possibile per esprimersi e, detto questo, non possiamo che interessarci a queste band e farne un po' di promozione.
Gabriele: Personalmente, da strimpellatore, sarei molto felice se qualcuno si interessasse alla mia musica, organizzare eventi con gruppi di vicenza a suonare è quindi un “fare agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te” e un buon modo di sentire musica nuova e vedere amici e conoscenti all’opera in qualcosa che non sia la solita scuola, le solite prodezze del sabato sera. Forse un modo anche di conoscere qualche altro lato di queste persone. Per quanto riguarda i gruppi già più affermati (pur restando di nicchia, sto pensando ai “Distanti” e ai “FBYC” che Alessio ha intervistato con splendidi risultati), c’è da dire che in Italia non siamo poi messi così male a livello musicale, ci sono un sacco di gruppi in gamba, il nostro è un modo di promuoverli nel nostro piccolo.
Bruno: con quale pretesa potremmo parlare d'altro? veniamo dalle cantine a dirla come dici tu, cerchiamo di comunicare alle persone la nostra realtà, quello che ci appartiene, non parliamo di fantasmi, i gruppi e le band che spingiamo, i ragazzi che intervistiamo, sono tutti gente della strada, come te, come noi.
- Qual è stata la reazione che voi giudicate più positiva nei confronti del vostro lavoro? E la più negativa?
Alessio: non saprei dire con precisione, certo quando vengono a farci i complimenti o a dirci che anche lui/lei, lettore x, scrive e gli piacerebbe pubblicare, ecco, quanco ciò accade, significa che stiam riuscendo in ciò che proponiamo. La reazione più negativa è sicuramente l'indifferenza, ma ci sprona a migliorare.
Gabriele: ce ne sono state varie, dal messaggio arrivato la notte che abbiamo dato il primo numero a un caro amico nel quale costui ci ringraziava per la piacevole lettura. Ai racconti di amici che, portandosi la fanza in viaggio, han conosciuto persone che sono rimaste piacevolmente colpite dal nostro lavoretto.
Reazioni negative specifiche non saprei bene, qualche volta ci è capitato di trovare fanze buttate con noncuranza per terra dopo che le avevamo smerciate e questo ci ha lasciati un po’ amari, però immagino sia normale che a qualcuno interessi meno il nostro lavoro di altri, poi magari eran tipi sbadati, suvvia.
Bruno: personalmente, un compaesano rimasto scoinvolto (in termini positivi) dall'esistenza della fanza. Se in cento copie che distribuiamo, anche solo una persona riesce a cavarne fuori qualcosa per se stessa, uno spunto di riflessione, un pensiero, io credo che dovremmo dirci soddisfatti, se poi qualcuno ci chiede di pubblicargli un racconto una poesia o qualsiasi altra cosa, allora non possiamo chiedere di più.
- Vicenza è un bel posto o fa schifo? Argomentate.
Alessio: Credo che Vicenza non sia malaccio, certamente, per chi ama la musica e le feste, i posti sono pochi e le offerte ridotte e ripetitive (certo se ti piace l'hardcore, l'hip hop o il reggae non credo ci siano molte altre città di provincia a questi livelli). Inoltre ora le cosa stanno migliorando, basta vedere l'apertura del Bocciodromo o come è stata subito accolta con una bella mobilitazione l'ultima ordinanza di Variati (che poi di fatto non cambiava quasi nulla) a testimonianza che di gente con voglia di fare ce n'è.
Gabriele: Vicenza ha i pregi e i difetti della città piccola. Il centro è relativamente tranquillo e spostarsi non è poi così problematico, ha dei posti molto belli e i colli berici sono splendidi se si evita di andarci la domenica pomeriggio (dove ci sono appunti i “passeggiatori della domenica pomeriggio”). Certo poi il fatto che sia piccola porta al fatto che a un certo punto le persone bene o male si conoscono tutte, capita che non ci sia niente da fare. Un problema appunto è il fatto che a un certo punto non si sa più cosa fare di nuovo, diventa un po’ complicato trovare nuovi stimoli. Per fortuna non siamo gli unici a pensarla così e comunque qualcuno che si adopera a rendere più vivibile la città c’è, sto pensando alle attività degli amici Elemento di Disturbo o alle attività e potenzialità del Bocciodromo!
Bruno: Vicenza è bella, basta prenderla come viene e non farsi troppe aspettative; certo alcune giornate sono mortificanti, ma stiamo lavorando anche a questo
- Progetti per il futuro?
Alessio: diciamo che La Lotta Armata Al Bar è stata ripensata all'interno di un "contenitore" che si chiama Onan l'Onirico e che si divide in produzioni editoriali, organizzazione di piccole serate/evento, distribuzione di dischi che più indipendenti non si può, produzioni pseudocinematografiche e tutto quello che ci verrà in mente. A proposito, se avete proposte, noi ci siamo!
Gabriele: Diciamo che per quanto riguarda la fanza non ci sono attualmente progetti di stravolgimento del format eccetera (qualche idea era venuta fuori per il sesto numero che poi è stato comunque fatto come sempre), ovviamente cercheremo di coinvolgere sempre più gente, che è uno degli obbiettivi principali di tutto l’ambaradan che facciamo in fondo.
Per quanto riguarda eventi e cose varie incrociamo le dita perché potremmo ampliarci da quel punto di vista organizzando qualche concertino non male, ma è tutto sempre sul forse (e lo sarà se tutto va bene fino al giorno prima), quindi sempre speranzosi per il futuro e come dice Alessio aperti a proposte di qualsiasi tipo.
Bruno: tanto sano amore, CIAO!